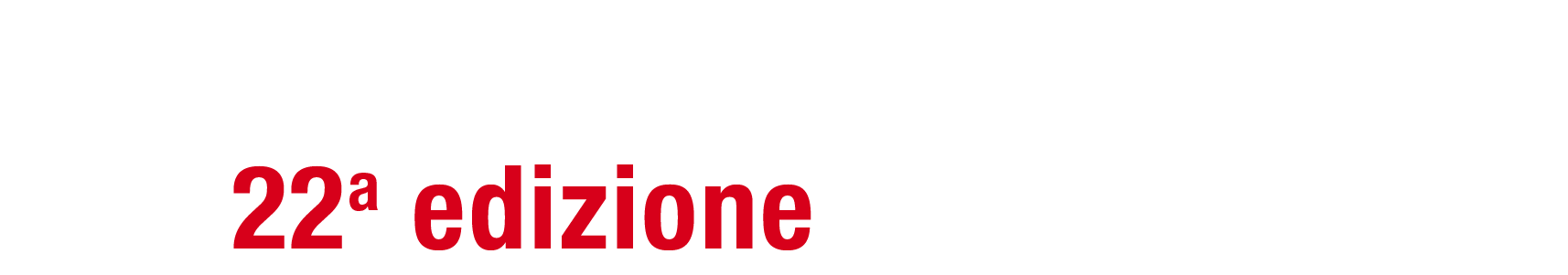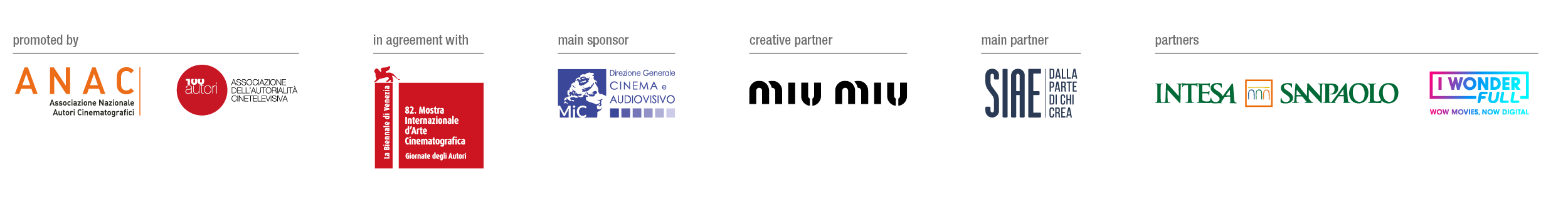Le Notti Veneziane sbarcano in Sala Laguna con una selezione che ci racconta di un paese che fa i conti con il concetto di storia, di altrove, e che torna ad abitare lo spazio familiare come luogo di costruzione e decostruzione
Tornano le Notti Veneziane, la finestra annuale delle Giornate degli Autori realizzata in accordo con Isola Edipo, dedicata all’anteprima mondiale di film italiani. La selezione di nove film, tra cui sei documentari e tre opere di finzione, valorizza l’eterogeneità dei modelli espressivi e degli orizzonti a cui rivolge il proprio sguardo e celebra il rinnovato eclettismo del cinema d’autore in Italia.
Le Notti Veneziane sbarcano in Sala Laguna con una selezione di numeri primi che ci raccontano di un paese che fa i conti con il concetto di storia, di altrove, che torna ad abitare lo spazio familiare come luogo di costruzione e decostruzione della propria misura nel mondo, dove si torna a fare i conti con i rischi e le possibilità di un amore folle, dove la maternità si accompagna a destini diversi, opposti. Immersioni che portano con sé tradizioni espressive anche molto diverse tra loro: dal documentario sperimentale passando per il documentario classico, approdando al cinema di finzione che utilizza il montaggio come spazio di creatività imprevedibile curvando poi subito verso un altro tipo di cinema che si affida più a una narrazione lineare per poi spalancarsi sulla capacità di far vibrare i propri interpreti e le proprie interpreti, tornando a un racconto composto da immagini di repertorio svelate.
Alle Notti il cinema documentario si fa gesto necessario per raccontare ciò che spesso resta fuori campo: legami familiari, passaggi generazionali, fratture interiori, comunità marginali e traiettorie esistenziali che si fanno racconto collettivo.
Quest’anno ci troviamo in un crocevia di ponti verso un altrove sempre diverso: accade nello sguardo colto e gentile di Massimiliano Battistella che con Dom – film di apertura delle Notti – ci porta accanto a Mirella, donna alle prese con la ricomposizione della propria storia. Lei dopo trent’anni a Rimini, dove fu accolta ancora bambina da una comunità impegnata nella tutela di minori vittime della guerra in Jugoslavia, torna a Sarajevo e per riconnettersi quelle radici mai perdute.
L’oltremare si fa oltreoceano in Life Beyond the Pine Curtain di Giovanni Troilo che ci porta in East Texas: terra lontana dalle narrazioni ufficiali americane esplorata con la guida della voce del celebre scrittore americano Joe R. Lansdale. È questa un’America forse invisibile, profonda, diffidente, viva che emerge dal racconto quotidiano di cinque persone la cui vita è specchio di un Paese in bilico tra vecchie paure e nuove speranze.
Riapre il sipario su un altro Paese Roland Sejko con Film di Stato: nella cifra della sua tradizione, il regista continua l’indispensabile lavoro di ricostruzione dell’immaginario dell’Albania e della sua storia attraverso un’operazione delicatissima. Lo fa raccogliendo materiali di archivio (alcuni inediti) e ricostruendo la narrazione dell’Albania del dopoguerra sottoposto al regime di Enver Hoxha e riflettendo così sul potere delle immagini e sul rapporto tra rappresentazione, verità, ideologie.
A muoversi in verticale nello spazio familiare tra intimità e pubblico e a fare i conti con la figura paterna sono due documentari: in Una cosa vicina, Loris G. Nese utilizza un linguaggio ibrido tra live action, archivio e animazione per raccontare il percorso di un bambino negli anni Novanta, costretto a crescere tra segreti familiari e assenze premature, fino a confrontarsi da adulto con il peso di un’eredità segnata dalla violenza.
In Toni, mio padre, Anna Negri ci regala un ultimo sguardo, a tratti feroce e ad altri dolcissimo, su un Toni Negri che negli ultimi anni della sua vita si apre a un dialogo con la propria figlia non accettando però di dismettere i panni di intellettuale politico facendo così emergere le contraddizioni dolorose di un certo modo di abitare la Storia e la propria intimità familiare.
Su un sentiero parallelo Indietro così! di Antonio Morabito ci riporta al centro dell’agorà: siamo nei laboratori teatrali di una Roma periferica e solidale, dove l’arte incontra la disabilità e diventa spazio di espressione, auto-narrazione e resistenza quotidiana. Un documentario dal sapore basagliano, di rara umanità che evita retorica e pietismi e sa restituire con ironia e rispetto la densità emotiva e sociale del lavoro con la disabilità mentale.
L’immersione nello spazio dell’intimità torna ad amplificarsi tra le righe dei tre titoli di finzione: con Confiteor di Bonifacio Angius – nel cast Geppi Cucciari, Edoardo Pesce e Giuliana De Sio – entriamo in contatto con un percorso esistenziale profondo e articolato. È l’ultimo atto filmico di una trilogia interiore iniziata dieci anni fa: una riflessione sul tempo, sull’amore perduto, sui legami familiari e sulla memoria personale che trasforma lo spazio autobiografico in una sofferta dichiarazione d’amore al cinema stesso.
A focalizzare l’intimità delle donne è Elisa Amoruso con Amata: film che riflette su maternità fra desiderio e rifiuto, su identità femminile e diritto di scegliere. Nel suo quinto lungometraggio di finzione la regista affronta questi temi delicati mettendo in dialogo due esperienze in un certo senso opposte: quella di chi partorisce senza volerlo e quella di chi vorrebbe ma non può. È un racconto a specchio, dolcemente potente, su desiderio, corpo, scelta. Nel cast Miriam Leone, Tecla Insolia, Stefano Accorsi, Donatella Finocchiaro, Barbara Chichiarelli.
A chiudere questo trittico è Tekla Taidelli che, a vent’anni dal sorprendente e viscerale esordio (Fuori vena), porta alle Notti 6:06: un romanzo di formazione notturno, allucinato e ossessivo, in cui l’iniziale bianco e nero lascia poi spazio al colore. Il film diventa metafora esistenziale, opera visivamente radicale e aperta a nuovi orizzonti, anche geografici, in cui forse il dolore della tossicodipendenza può essere lenito da un incontro salvifico.
Questa costellazione di nove opere, ciascuna peculiarmente singolare, traccia una sorta di mappa emotiva e politica del nostro tempo attraverso una varietà di linguaggi e di sguardi che condividono una tensione comune: la ricerca, tanto dolorosa quanto necessaria, del proprio filo rosso attraversando eterogenee zone d’ombra di storie familiari e della Storia collettiva.